
VIAGGIO AL TERMINE DELLA NOTTE, di Louis-Ferdinand Céline (Corbaccio)

Recensione 1
Viaggiare è come fuggire, è un modo di cambiare uno stato temporaneo, una trasformazione che procede con la scoperta di nuovi luoghi, culture e persone diverse. Un modo per migliorare la propria esistenza, fuggire per andare alla ricerca della libertà.
Tante possono essere le mete, ma si giunge ad una sola destinazione quando il viaggio si conduce attraverso le vie tormentate dei pensieri della nostra mente.
È un viaggio che attraversa l’inverno e che percorre il buio della notte, dove ognuno cerca il passaggio attraverso strade felici, ma si accorge che qui niente è illuminato. Il buio è la sensazione che persiste per tutto questo lungo viaggio, l’angoscia e il tormento che ci procura la notte di un sogno; incubo che non vede nessuna speranza di arrivare ad una metà tranquilla; sollievo che ci dona l’alba di un nuovo giorno.
Viaggio al termine della notte è il percorso della condizione umana di un secolo crudele e turbolento che è stato il novecento, e che il nostro autore ha dovuto attraversare tra la vita e la morte.
Ferdinand Bardamu, il nostro protagonista, ha vent’anni, studia medicina e guarda la vita con rabbia, percependo la sua malvagità e il suo degrado. Arruolatosi patriotticamente quasi per gioco, sperimenta le atrocità della guerra.
Questo giovane ragazzo, sembra essere il protagonista di una autobiografia trasfigurata che Célin mette in scena per compiere il viaggio della sua vita, e attraverso sfondi prevalentemente diversi, racconta una verità disumana di una condizione sociale ormai marcescente.
Un viaggio che attraversa la guerra e la miseria, e che arriva nell’Africa coloniale oppressa dalla predazione criminale dell’occidente capitalista, approdando poi negli Stati Uniti d’America, fabbrica fordista totalitarista che semina morte e genera pazzi.
Ma nel momento in cui tutto sembra prendere la sua dimensione, Bardamu rinuncia all’amore e agli affetti, abbandona il suo lavoro da operaio, per ritornare in Francia e finire gli studi di medicina. Diventerà il medico di quella gente rifiutata e respinta dalla società, emarginata nelle sue idei e nella sua locazione, situata in una periferia di una città che mostra solo degrado, bruttura e miseria.
Non fa nessuna differenza rischiare di morire ammazzati in guerra o morire di fame in pace. Scendere in un rifugio valeva dire mettere il primo piede in quella che sarebbe stata la loro fossa, erano le prove generali di una commedia; vite di attori senza speranza che la sorte aveva voluto in quello scenario bellico di un mondo delirante. Un mondo ormai marcio, afflitto dalla tubercolosi e dalla malaria, substrato di vermi che circolano ancora in posizione eretta.
È un trattato di anime in pena che vede recitare le parti di un romanzo duro, disumano e sarcastico, dove è la tragedia della condizione umana a scorrere senza vedere altra soluzione che la morte.
Questa è la condizione che deve fare i conti con un progresso che sa generare solo angosce, malinconia e tristezza, e una scarica elettrica può essere la soluzione unica per annientare ogni mente, sopprimendo completamente l’esistenza della razza umana.
Alienamento di una generazione estraniata, lasciata in balia di una logica che genera solo pensieri malati, afflitta dagli orrori di una guerra e dalle diversità sociali, economiche e culturali.
È questo il viaggio che Louice Ferdinand Cèlin affronta insieme a Bardamu, percorrendo il terreno arido che tormenta gli uomini in questo cupo viaggio, attraverso la ricerca di risposte ultime, quelle che nessuno sembra voler affrontare per diventare se stessi prima di morire; viaggio ormai consapevole di una grande e inconfutabile impotenza umana.
Unica è la prosa che l’autore ci consegna, tanto da percepire tutto il veleno posto in ogni parola, dalla sintassi frammentata, scandita dal ritmo breve che suona una musica jazz, e che genera sensazioni continue e veloci di una letteratura nuova e tormentata, che ha a che fare non con la bellezza, ma solo con la dura verità.
Verità che non da scampo, ad una vita che gira lenta come una giostra, con la musica di un organo che suona tra le luci colorate e le sue vecchie bancarelle, immersa nei pensieri cupi che giungono piano alla mente.
E mentre si va avanti tra uno scontro e un tirassegno, è breve il lampo di una foto che si spegne e svanisce nei nostri occhi, trovandoci tutti con le mani tra le mani, come una zingara che ci legge il futuro dopo aver percepito il passato.
Ma al termine della notte, nella la mente, non rimane altro che l’eco di una malinconica frase, letta alla fine di quel tunnel e che ci ripete insistentemente: Le jeux sont faits, rien ne va plus.
Buona lettura.
Recensione di Giuseppe Carucci
Recensione 2
Un viaggio oltre noi stessi, oltre il finire del giorno, oltre la stupidità umana. Oh, come s’ingegna l’uomo per fare le guerre, tanto che a volte è il nemico meno dannoso dell’amico. Questo accade purtroppo ancora oggi, nel terzo millennio. Si continua a scendere e l’amore rimane un giardino per pochissimi istanti, riservati a una manciata di eletti. Il ritmo, un ritornello, sempre quello, cantato dall’anima del barbone in mezzo alla gente, spesso ignorato, calpestato, deriso. E la sua anima, nemmeno lui la vede.
Il titolo deriva da una strofa di una canzone cantata dall’ufficiale svizzero Thomas Legler. «La nostra vita è un viaggio / in Inverno e nella Notte / noi cerchiamo il nostro passaggio / in un Cielo senza luce». Era il 1793, l’ufficiale combatteva per Napoleone, e Louis-Ferdinand Céline la sceglie come esergo al romanzo. Segue una definizione del viaggio molto citata e amata: «Viaggiare, è proprio utile, fa lavorare l’immaginazione. Tutto il resto è delusione e fatica. Il viaggio che ci è dato è interamente immaginario. Ecco la sua forza. Va dalla vita alla morte. Uomini, bestie, città e cose, è tutto inventato. È un romanzo, nient’altro che una storia fittizia.»
A tradurre di recente il capolavoro céliniano, è stato il vincitore del Premio Strega nel 2000,
con il romanzo “N”, dove la figura di Napoleone è centrale e funzionale al quesito esistenziale: è meglio modificare il mondo attraverso l’azione eroica, o cercare di dargli un senso attraverso la scrittura? Chissà se tradurre Céline ha dato qualche spunto a Ernesto Ferrero? Intanto il protagonista del “Viaggio” da lui tradotto, non ha niente dell’eroe e nessuna intenzione di assomigliargli.
Si ritrova in guerra senza capire chi è il nemico e perché esiste un nemico. «Io non sapevo.» Forse gli altri, il Colonello, i tedeschi lo sapevano. Ma il combattente Ferdinand Bardamu non riesce a farsene una ragione. Fa la guerra senza condividere un grammo del pensiero che la anima. Rimanendo puro nel suo pensare la guerra una «imbecillità infernale», ci racconta del sodato Kersuzon, ucciso per sbaglio da francesi «che ci avevano scambiati per altri».
Narratore e protagonista, Ferdinand Bardamu impersona l’autore stesso. Il suo cognome risulta dall’unione delle parole francesi barda (argot per equipaggiamento militare) e mu (mosso, participio passato del verbo “mouvoir”, muovere). La trama vedrà Bardamu piano piano disfarsi dei buoni sentimenti e dell’ottimismo, che appartengono a tutti i giovani secondo un pensare comune tradizionale.
L’opera è a sfondo autobiografico, come tutti i romanzi di Céline. Bardamu, dopo aver combattuto la Prima guerra mondiale, s’imbarca per l’Africa coloniale, dove impara come si muovono i colonizzatori francesi, poi per gli Stati Uniti del primo dopoguerra, dove diventa operaio della Ford e non soccombe per un pelo annientato dalla società di massa nascente. Qui conosce Molly, una prostituta che lo ama veramente e che lo sprona a essere se stesso, anche a costo di perderlo. Anche lui la ama, a modo suo, dedicandole le pagine più toccanti e liriche di tutto il libro. Ritorna in Francia, diventa medico, apre uno studio e fa la fame in un degradato sobborgo di Parigi, infine inizia a lavorare presso un istituto di igiene mentale. Léon Robinson è il suo compagno di sventure, nonché alter ego, grillo parlante, antieroe vile e assassino.
Pessimista sconfortato, Céline restituisce al lettore il senso di aver toccato il fondo e grattato tutto il marcio che vi si trova, non perdonando niente al genere umano, alla società, alle istituzioni, alla politica e alla vita in generale. Verso la fine del libro, il narratore Bardamu, che sta lavorando in un manicomio, sottolinea che la famiglia e l’uomo sono una sorta di «marciume sospeso», che «non si sale nella vita, si scende», «istruzione e forza» aiutano a capirlo.
Ma il vero exploit letterario in “Viaggio al termine della notte” Céline lo compie nello stile e nell’uso del linguaggio. «Ho inventato una lingua antiborghese» dirà a un giornalista. «La sua lingua è di fatto diversa dal francese schematico, logico, cartesiano, che allontana da sé la lingua viva ossia il parlato», ci dice Stefano Lanuzza, uno dei più grandi conoscitori dell’opera céliniana in Italia. Come scriverà in “Bagatelles”, lui era contro «il francese degli studi classici, […] ripulito, […] strofinato, […] accademia Goncourt, […] il francese schifoso per eleganza» e piuttosto «ideale continuatore del superespressivo Rabelais». Il linguaggio usato si declina a perfezione con i suoi personaggi, abbondano le ellissi, le iperboli e l’argot, l’oralità della fauna umana contemplata. Appena uscita, l’opera fu accolta con successo: era un comune argomento di conversazione serale. Anche Simone de Beauvoir racconta che lei e Sartre impararono a memoria interi brani del romanzo, e che Sartre ne aveva fatto un modello.
Peccato che Céline sia stato giudicato male per il suo antisemitismo e collaborazionismo, costretto persino all’esilio. Altri scrittori o uomini politici che si sono esposti molto più di lui non hanno avuto lo stesso trattamento. Anche Dostoevskij era antisemita e Mitterand s’intratteneva con filonazisti. Non era un fenomeno isolato. Accadeva che scrittori e politici frequentassero personaggi influenti conniventi con il potere, e che si esprimessero a favore di politiche razziste e a servizio dei governanti dell’epoca. Ad ogni modo bisognerebbe distinguere l’opera dal suo autore. Opera che lui stesso definisce comunista.
Nella lettera che scriverà a Gaston Gallimard, nel 1932 per ottenere una pubblicazione, descrive il suo capolavoro come un grande affresco, populismo lirico, comunismo con un’anima. Un’opera birichina, viva. Settecento pagine di viaggi attraverso il mondo, gli uomini e la notte, e l’amore, l’amore che t’insegue, ti rovina, e che ti lascia sconfitto, ancor più miserabile, solo e svuotato.
Un magistrale spaccato del secolo scorso. Un ritratto che non perdona. Un’umanità degradante e degradata che si riscatta nella parola orale gergale e nella parola scritta innovativa e iconoclasta. Senza gesti eroici. Senza morali sovrastanti. Senza religioni. Una nuda e cruda libertà di parola. Di pensiero. Tanto tutto si putrefà. Prima o poi.
Prima puzza. E poi mentre il corpo diventa polvere le parole scritte rimangono e si fanno veicolo di argot vivente.
Recensione di IO LEGGO DI TUTTO, DAPPERTUTTO E SEMPRE. E TU? di Sylvia Zanotto
VIAGGIO AL TERMINE DELLA NOTTE Louis-Ferdinand Céline

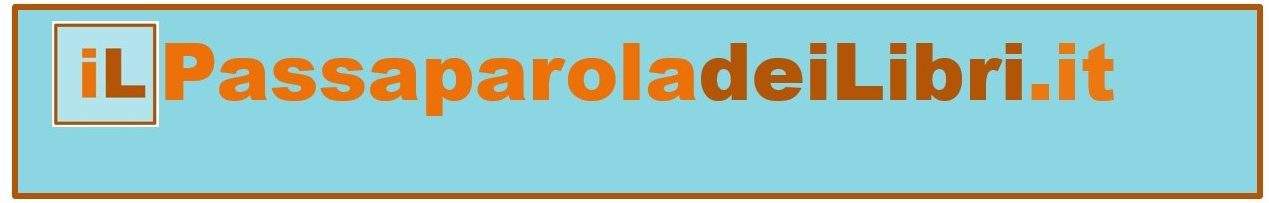


Commenta per primo